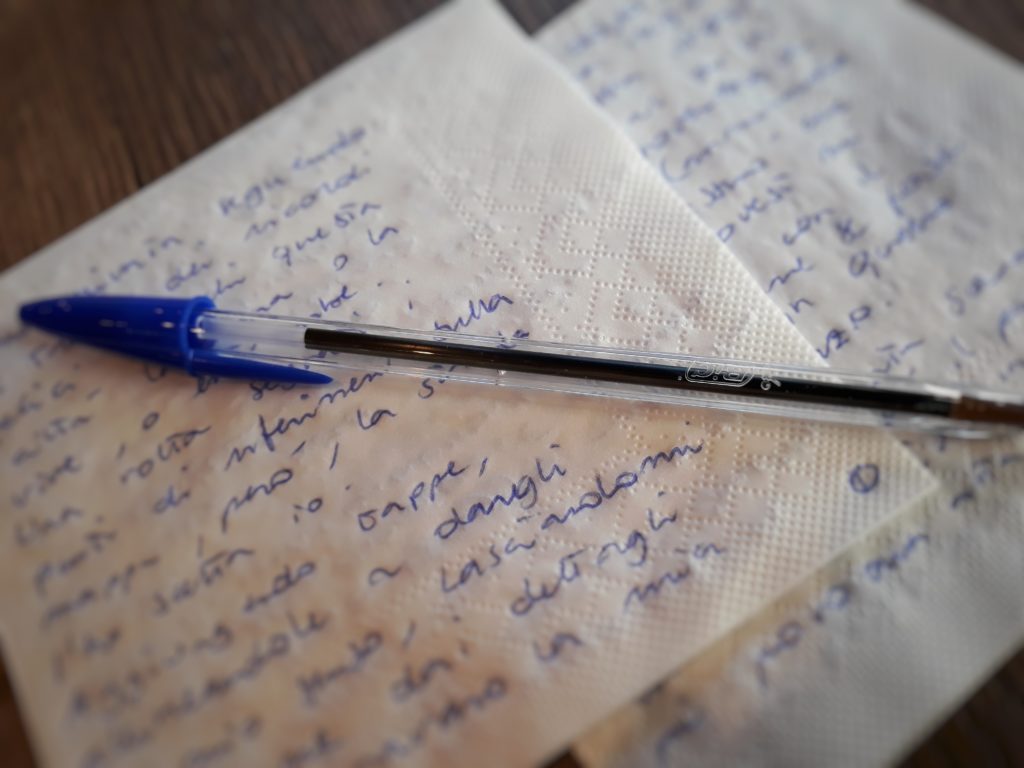17 Set #seguilatuabussola – Texas, nuvole e vulnerabilità

È la terza volta che passo per il Texas, ma non posso certo dire di conoscerlo. Forse di avere raccolto qualche tessera in più del puzzle, ma non so se questo fa più chiarezza, o più confusione.
La prima volta ci sono arrivata per partecipare a un matrimonio. Che si sa che sono allergica a tutte le cerimonie, e in realtà io gli sposi nemmeno li conoscevo. Ma figuriamoci se mi facevo scappare l’opportunità: Dallas, la comunità italo-americana, le enormi case dei suburbs, i festeggiamenti fino a tarda notte.
La seconda volta ero a nord, lungo la traccia della Route 66, attraverso cittadine che si aggrappano alla nostalgia di un passato di vacanze fatte caricando la famiglia in auto e guidando giornate intere, di un’iconografia pop che cerca di sopravvivere nei motel restaurati e nei menu dei diner, lungo una strada uguale a se stessa da mezzo secolo.
E stavolta, la terza, non lo so ancora cosa cercavo nelle centinaia di miglia che ho percorso andando sempre più a ovest. Partendo da svincoli a otto corsie, attraversando pianure interrotte da edifici simili a sogni, o miraggi, arrampicandomi fino al buio per vedere le stelle, rincorrendo la meraviglia che solo la natura mi sa regalare.