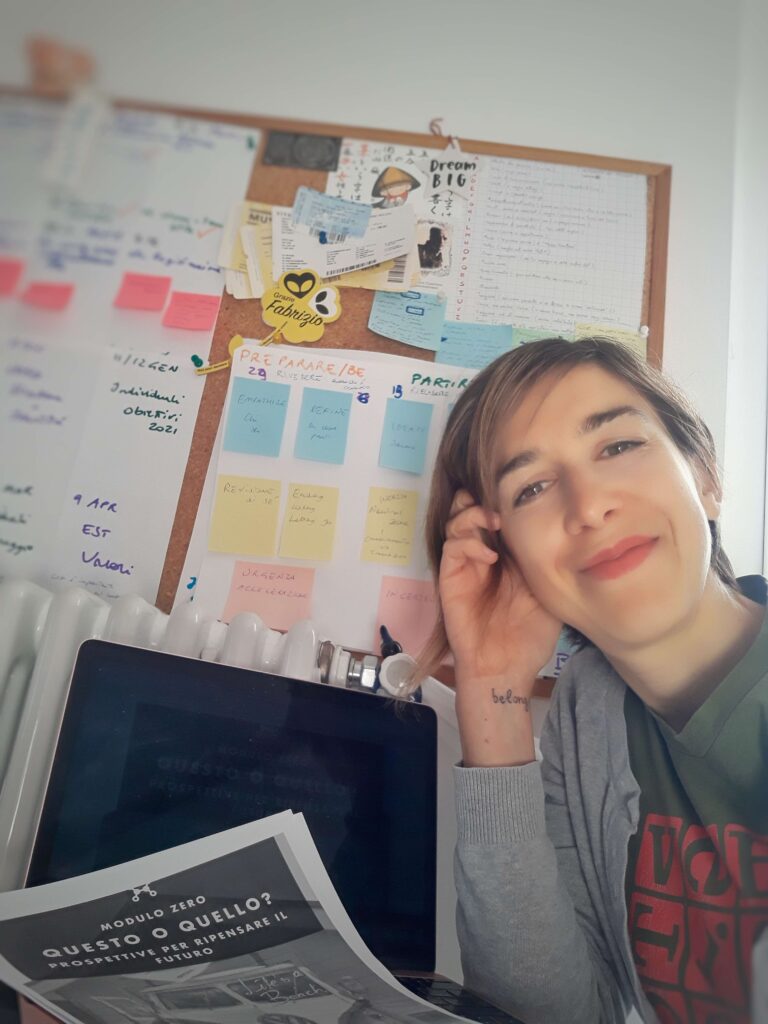09 Mar Perché ogni lavoro fa schifo, e come disegnarlo meglio

Tolstoi diceva che “Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo.’’ Parafrasando, tutti i lavori si somigliano, ma ogni lavoro fa schifo a modo suo.
È sempre un argomento delicato, quello del lavoro. Ultimamente, anche di più.
Chi sembra quasi sentirsi in colpa anche solo ad averlo, un lavoro, figuriamoci lamentarsene, con tanta gente che il suo lavoro non ce l’ha più.
Chi “tanto adesso non è il momento di cercare”, che è sempre stata la scusa che si è raccontato, ma che adesso suona più convincente.
Chi ribadisce che tanto si sa che le aziende sono fatte così, e non so se ne è davvero convinto o se non si pone nemmeno la domanda del perché non inizi proprio lui a cambiare qualcosa.
Ne sento tanti, di discorsi così. Il lavoro da remoto ha tolto le pause caffè in ufficio, e allora si cercano opportunità alternative di scambio, in cui un po’ sfogarsi e un po’ riflettere. E io sono lì, come trainer, o come coach, in ogni caso elemento neutrale ma da cui si può avere un confronto diverso, un po’ specchio che non fa sconti quando ti stai solo lamentando e un po’ incoraggiamento a rimboccarsi e mettere in pratica idee e strumenti che stiamo condividendo.