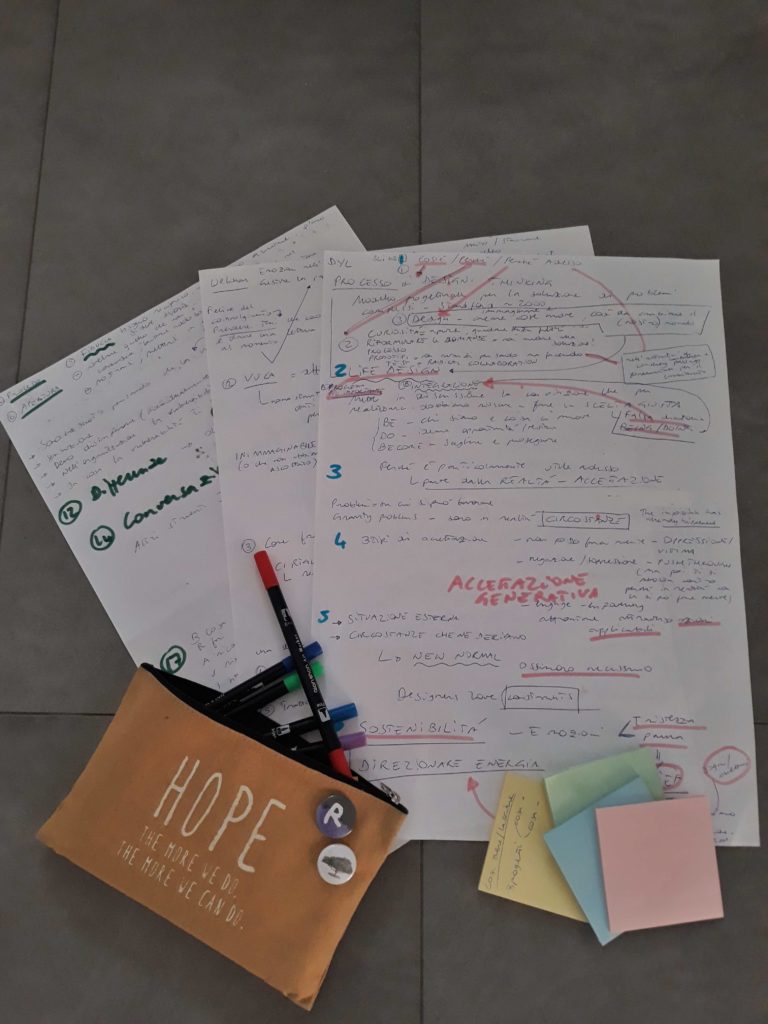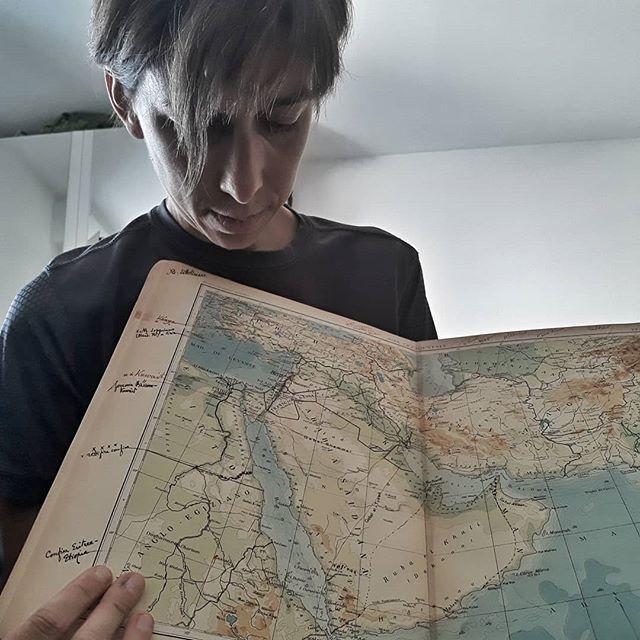16 Giu La fisica dell’inerzia

Al liceo la fisica mi sembrava una grande fregatura. Alla prima lezione mi avevano illuso che in quelle formule avrei capito il funzionamento del mondo, alla seconda già mi dicevano che però dovevo considerare un sistema ideale, in cui punti senza peso e senza dimensioni si muovevano in uno spazio senza aria e senza gravità. Un interessante esercizio teorico, ma io volevo capire come funzionavano davvero le cose.
Di quelle formule ricordo ben poco, ma in questi giorni ogni tanto ci penso.
Per settimane ho rallentato e rallentato, e adesso cavoli se la sento, l’inerzia che rende difficile riprendere il movimento.
Principio d’inerzia: un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza esterna a modificare tale stato.
Mi sento proprio così. Magari non ferma, ma certo frenata. Come se ogni azione richiedesse una quantità di energia superiore al consueto. Un'energia che fatico a ritrovare.