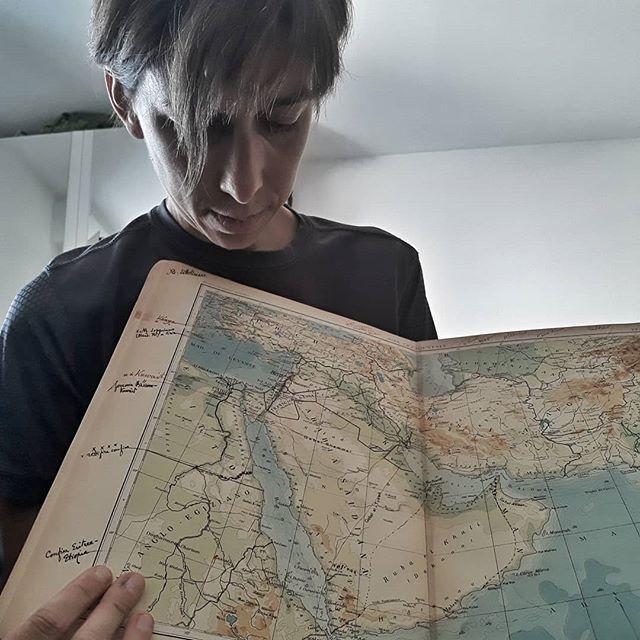03 Nov Più che una storia, un colabrodo (e come non farsi fregare dai buchi)

Una delle cose che mi affascinano maggiormente, nel confronto con i clienti che incontro, è quanto riusciamo a essere tutti diversi e tutti uguali. Cioè, ciascuno arriva con la sua personale e unica esigenza, il suo vissuto, la sua esperienza. Con paure, attitudini, convinzioni.
I meccanismi di difesa, però, quelli che spesso sono anche quelli in cui ci incastriamo, alla fine si assomigliano tutti.
Fingiamo di non vedere anche quando abbiamo le cose sotto gli occhi, ci inventiamo una realtà alternativa e parallela, ci concentriamo solo su un dettaglio invece che guardare il quadro completo.
Qualche settimana fa parlavo con Sandra. Mi raccontava la sua preoccupazione per un’importante scadenza di lavoro, e come per questa avesse dovuto rinunciare al consueto ritorno estivo presso la famiglia di origine, di come un po’ temesse l'idea di un'estate solitaria in città, mentre avrebbe voluto staccare un po’, immergersi nella natura, respirare un po’ d’aria dopo tanti mesi di confinamento.
Scavando un po’ più a fondo, però, avevo scoperto che la scadenza non era così imminente, che le amiche non erano partite senza di lei, che nessun piano era stato proposto e bocciato.