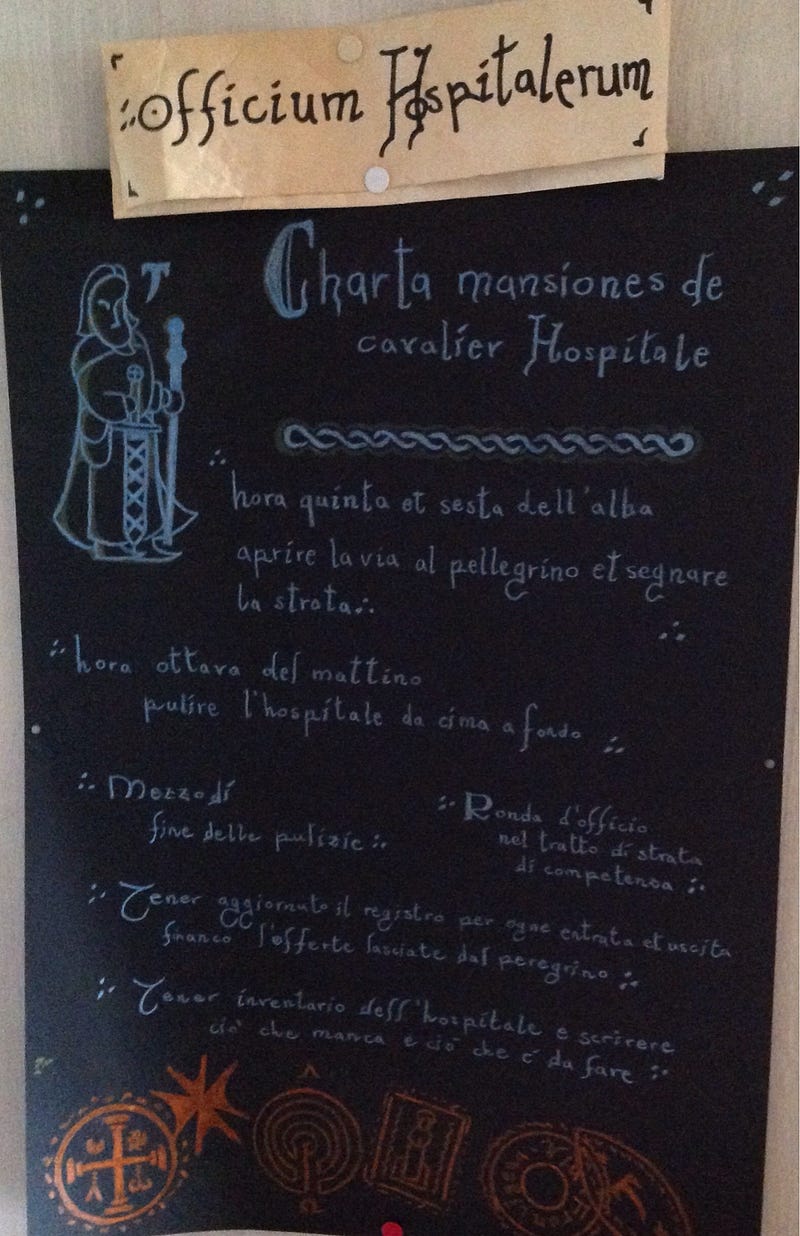Confesso.
Ero tentata dall'idea di scrivere un intero post sulla
fenomenologia delle riproduzioni in plastica dei piatti, che qui in Giappone funestano le vetrine della maggior parte dei ristoranti, persino quelli dove poi si mangia bene. Ma forse è meglio cominciare invece dal principio.
Non è il primo viaggio in un luogo in cui non solo non conosco la lingua, ma anche la scrittura è un ostacolo a qualsiasi ipotesi di interpretazione.
Eppure stavolta, arrivata a Tokyo nel caos di Akihabara, tra le insegne luminose e la folla della domenica pomeriggio a passeggio,
ho avuto un attimo di spaesamento, come se fossi in una bolla che non poteva in alcun modo trovare un contatto con l'esterno.
Non avere un linguaggio comune mi ha fatto trascorrere intere giornate in un silenzio quasi assoluto.
Se io non conosco una parola della loro lingua,
i giapponesi da parte loro pare che con l'inglese siano in una relazione complicata. C'è chi se la cava, ma a modo suo - ed ecco così frasi, probabilmente frutto della traduzione letterale di espressioni locali, che in inglese suonano decisamente comiche. C'è chi ha invece imparato a memoria le sole espressioni che gli servono nei confronti del turista di turno - sa quindi dare una spiegazione purché non preveda alcuna interazione di ritorno. E poi c'è chi, semplicemente, l'inglese non lo sa e sta bene così.





 Pranzo con un’amica che non vedevo da qualche settimana. Ci corriamo incontro e ci abbracciamo ridendo. Mi dice che la colpisce il mio sguardo, al tempo stesso pieno di pace e spalancato su quello che sta per succedere.
Pranzo con un’amica che non vedevo da qualche settimana. Ci corriamo incontro e ci abbracciamo ridendo. Mi dice che la colpisce il mio sguardo, al tempo stesso pieno di pace e spalancato su quello che sta per succedere.
 Confesso.
Ero tentata dall'idea di scrivere un intero post sulla fenomenologia delle riproduzioni in plastica dei piatti, che qui in Giappone funestano le vetrine della maggior parte dei ristoranti, persino quelli dove poi si mangia bene. Ma forse è meglio cominciare invece dal principio.
Confesso.
Ero tentata dall'idea di scrivere un intero post sulla fenomenologia delle riproduzioni in plastica dei piatti, che qui in Giappone funestano le vetrine della maggior parte dei ristoranti, persino quelli dove poi si mangia bene. Ma forse è meglio cominciare invece dal principio.

 Il viaggio inizia quando tiro fuori dall’armadio lo zaino. L’ho comprato dieci anni (e molti ricordi) fa, la prima volta che sono partita veramente sola. La prima volta che ho provato a camminare sulle mie gambe (in ogni senso). Ed ho scoperto che in fondo ne ero capace.
Forse anche per questo, mentre ciclicamente svuoto armadio e cassetti eliminando senza pietà tutto quello che non è strettamente necessario, da questo zaino ormai malandato e che ha bisogno di continui rattoppi non riesco ancora a staccarmi.
Mi piace il rito di aprire i cassetti e scegliere ciò che porterò con me.
Il viaggio inizia quando tiro fuori dall’armadio lo zaino. L’ho comprato dieci anni (e molti ricordi) fa, la prima volta che sono partita veramente sola. La prima volta che ho provato a camminare sulle mie gambe (in ogni senso). Ed ho scoperto che in fondo ne ero capace.
Forse anche per questo, mentre ciclicamente svuoto armadio e cassetti eliminando senza pietà tutto quello che non è strettamente necessario, da questo zaino ormai malandato e che ha bisogno di continui rattoppi non riesco ancora a staccarmi.
Mi piace il rito di aprire i cassetti e scegliere ciò che porterò con me.